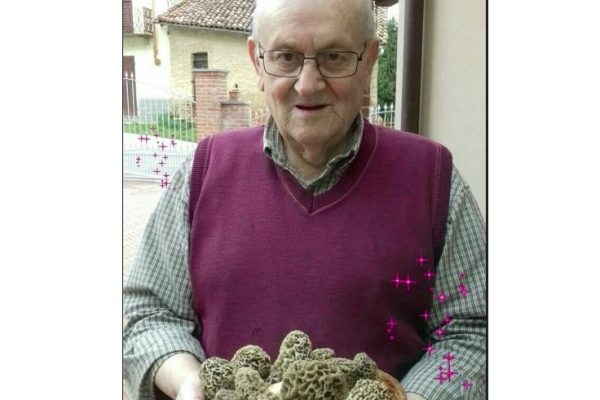Con una cerimonia organizzata dalla Prefettura in collaborazione con la Provincia, l’Ufficio Scolastico Territoriale e l’Israt, ieri (giovedì), nella Sala Consiliare del Palazzo della Provincia, sono state ricordate le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata in occasione del Giorno del Ricordo, che cade il 10 febbraio, istituito a qauesto scopo dalla Legge 92 del 30 marzo 2004.
Tra le varie autorità civili e militari presenti il Presidente della Provincia, Paolo Lanfranco, il sindaco Maurizio Rasero e il Prefetto Alfonso Terribile. In sala anche alcuni componenti della Consulta provinciale degli studenti e una rappresentanza di alunni del liceo scientifico Vercelli ad approfondire l’argomento con l’aiuto di fotografie e filmati.
Nel corso della cerimonia sono intervenuti Mario Renosio, direttore scientifico dell’Israt, e Andrea Rocco, responsabile della rete museale e curatore scientifico della Fondazione Asti Musei, invitato in quanto appartenente ad una famiglia di esuli istriani.
Gli interventi
“Una giornata, questa, per apprendere, conoscere – ha esordito Paolo Lanfranco – ma anche per ricollocare in una nuova dimensione delle vicende storiche”, un massacro dimenticato a lungo, iniziato in modo evidente in due momenti ben precisi: nel settembre 1943 e nel maggio 1945. “Una tragedia che va vista in un contesto particolare – ha considerato Maurizio Rasero – causata da situazioni che risalgono ai cinquant’anni precedenti. Una ferita ancora aperta, dove anche l’inserimento degli Italiani esuli non è stato facile né scontato”.
Il Prefetto Terribile ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva e consapevole dei giovani alla vita civile, condizione indispensabile per il futuro della nostra comunità, ricordando poi il sacrificio “che molti Italiani hanno compiuto in modo inconsapevole, senza aver commesso alcun reato”.
Le parole di Mario Renosio
Mario Renosio ha invece proposto un’interessante ricostruzione storica in cui ha sinteticamente analizzato le vicende del confine orientale, una situazione che ha avuto esito solo nel 1975 con la stipula del Trattato di Osimo. “Un tema estremamente complesso – ha detto – dove bisogna ricercare gli eventi e inserirli nel contesto senza rimozioni e negazionismi, approccio corretto per avere una visione imparziale di fatti che coinvolsero 300mila Italiani che condivisero la sorte con altri 18milioni di Europei”.
La testimonianza di Andrea Rocco
Andrea Rocco, infine, ha ricordato le vicende del padre e dei nonni che lasciarono Rovigno d’Istria nel 1947. “Inizialmente – ha raccontato – partì mia nonna con mia zia, in seguito mio nonno con mio padre che, essendo minorenne, ebbe bisogno di un’opzione firmata dal genitore, unico documento che conserviamo ancora. La loro partenza – ha continuato – fu un po’ diversa da quella della maggioranza degli Istriani perché mia nonna non volle passare per il campo profughi di Genova (uno dei 109 in tutta Italia) e venne destinata a Masone, dove mio nonno trovò subito lavoro come aiuto panettiere. Poi, negli anni ’70, si trasferirono a Castell’Alfero. Fu solo nel 1977 che mio padre tornò a Rovigno. Ma tra gli amici rimasti trovò ancora molta ostilità”.
Gli studenti
Da sottolinare, infine, la partecipazione attiva degli studenti alla cerimonia. In particolare Alessio Casetta, Gioele Mancino e Alessandro Musso (classe V C del liceo Vercelli) hanno formulato alcune domande ai relatori, mentre Giorgio Gaiotto, Lorenzo Giovine, Gino Spertino, componenti della Consulta provinciale degli studenti, insieme al presidente Mattia Monticone, hanno letto alcuni passi tratti da opere e testimonianze degli esuli Enzo Bettiza, Lina Galli, Guido Miglia e Marisa Madieri.