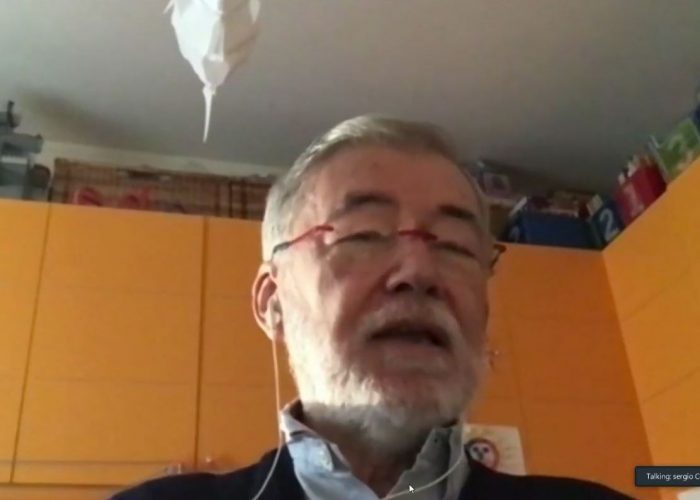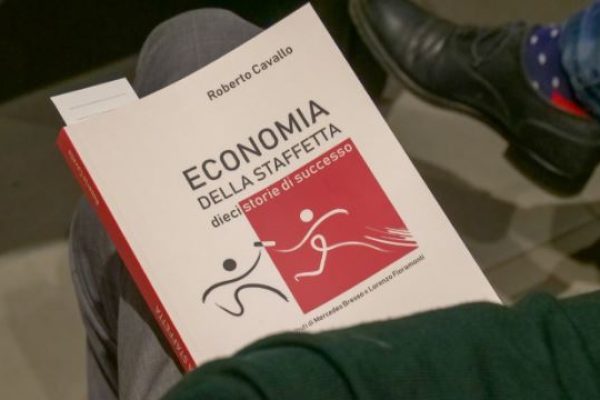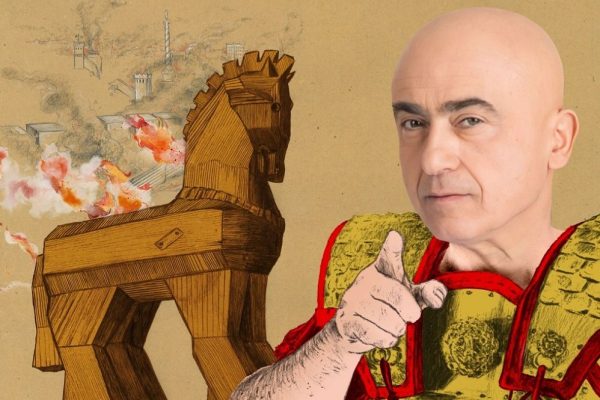Sergio Cofferati al festival Passepartout
Sergio Cofferati, domenica scorsa in collegamento con il festival Passepartout, ha ripercorso la nascita e le tappe più importanti della storia del sindacato. Un viaggio che inizia nel 1848 e arriva ai giorni nostri.
E’ infatti a partire dalle rivoluzioni del 1848 che si sviluppano le Società di Mutuo Soccorso, che si prefigurano più come forme di welfare autorganizzato basato su servizi definiti e dettagliati con caratteristiche di mutualità e solidarietà tra lavoratori, l’autogestione dei fondi e, spesso, un «codice etico e morale» dei comportamenti degli associati.
Cofferati ha sottolineato che il primo congresso nazionale delle società di mutuo soccorso si svolse proprio ad Asti nel 1853.
Asti, città che fu industriale. Inevitabile per il giornalista Beppe Rovera che ha accompagnato l’incontro non ricordare la storia della nostra città e il piazzale gremito di lavoratori di fronte alla Way Assauto.
Tutto è oggi molto diverso. E’ cambiato il contesto ed è cambiato il sindacato.
Sergio Cofferati nel 1994 succede a Bruno Trentin nel ruolo di segretario generale della Cgil. Di quel periodo viene spesso ricordato il no alla modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, per il quale il 23 marzo 2002 al Circo Massimo di Roma una folla di circa tre milioni di persone partecipò a quella che si ricorda come una delle maggiori manifestazioni italiane del dopoguerra.
Oggi che fine ha fatto il sindacato?
La domanda che dava il titolo alla serata è anche quella che sono in molti a porsi, anche tra il pubblico. Tra i presenti anche il segretario generale Fiom Cgil Asti, Mamadou Seck.
Per Cofferati il sindacato oggi ha problemi molto delicati da affrontare e mai visti prima. Diventa quindi fondamentale «conoscere e rappresentare i nuovi lavori. Come si trasforma il lavoro da casa, le attività di servizio? Questo lavoro ha bisogno di essere conosciuto e riconosciuto».
Stimolato dalla domanda di Rovera sulla contrapposizione lavoro-ambiente, citando il caso dell’Ilva, Cofferati ha detto: «Il Recovery Fund deve servire a rilanciare il Paese e a investire in ricerca e innovazione perché le attività crescano. Credo che con queste risorse, per il caso di Taranto, si potrebbe investire nel progetto acciaio verde (quello che viene prodotto con altiforni alimentati a idrogeno)».
Un’altra significativa difficoltà che il sindacato incontra oggi riguarda la comunicazione. Ai tempi delle grandi fabbriche un sindacalista da solo poteva parlare a migliaia di persone riunite. Oggi i luoghi di produzione sono più piccoli e occorrono modalità diverse per arrivare a tutti, per essere vicini alle persone.
L’intervento di Ernesto Galli della Loggia

L’intervento di Cofferati è stato seguito dall’ultimo appuntamento in programma del festival, quello con il professor Ernesto Galli della Loggia in collegamento video, introdotto dal giornalista Beppe Rovera.
Galli della Loggia ha definito quello che va dal 1920 al 2020 come il secolo lungo perché è uno spazio che contiene una serie di fratture che hanno determinato una svolta storica. E’ questo il tempo delle “fini” di cui il professore ha offerto al pubblico l’approfondimento attraverso il secolo.
Le due guerre mondiali e l’avvento della modernizzazione segnano la fine dell’identità lunga dell’Europa, la fine del suo ruolo mondiale. Ha ricordato che le morti causate dalla Spagnola furono in qualche modo «inglobate» in quelle della Prima guerra mondiale e che con la Seconda guerra mondiale la potenza distruttiva entrò nella vita quotidiana perché le morti riguardarono molto i civili.
Oggi il secolo lungo assiste alla fine della politica, finisce perché finiscono elementi sociali e strutturali. C’è uno svuotamento della dimensione politica e dell’utopia che consentiva di guardare al futuro in maniera diversa. Il professore ha anche evidenziato come ci sia oggi una «liquidazione del passato», ma di conoscerlo non si può fare a meno e che porsi delle domande con la voglia di approfondire ciò che è stato è fondamentale. D’altronde suscitarle è proprio l’intento di Passepartout che anche quest’anno, nonostante le difficoltà legate all’emergenza, è riuscito a portare in città 25 relatori di primo piano a discutere sul tema “1920-2020: Proibito”, coinvolgendo ogni sera un pubblico numeroso, anche se limitato al numero consentito dalla normativa anti Covid.
«Il pensiero è l’anima del nostro festival», ha ricordato in conclusione il direttore scientifico di Passepartout, Alberto Sinigaglia, che insieme alla Presidente della Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti, Roberta Bellesini, ha dato appuntamento all’edizione 2021.
L’idea e il tema sono già in cantiere, ma non è il tempo di svelarli.
Alessia Conti